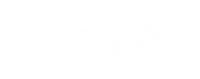Santo Stefano di Sessanio (Foto di Daniele Kihlgren)
Lo scorso 2 aprile ho avuto l’onore di essere invitato a parlare al Forum dal tema “Voci ed esperienze dai Borghi d’Italia” che ha concluso la 3^ edizione del Festival Cinematografico Borghi sul Set organizzato da Italia Nostra.
L’occasione mi ha consentito di conoscere Maurizio Cesprini, Presidente Fondazione CANOVA che ha mostrato la luminosa esperienza di Borgo di Ghesc in Val d’Ossola, abbandonato da oltre 100 anni ed ora splendido esempio virtuoso di vita e di studio.
nonché i due architetti Andrea Scotton e Arianna Pirazzi i quali, seguendo l’esempio di Ghesh, da circa 7 anni con altri 5, che io ho definito “eroi coraggiosi”, si sono trasferiti – per restaurare, ricostruire e riportare vita – nel bellissimo Borgo di Veglio[1], nella Val d’Ossola, un borgo che risultava non più abitato da circa 60 anni, a causa di un finto allarme frana messo in giro alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, alla ricerca di manodopera nelle industrie a valle
Il Forum mi ha consentito, finalmente, di conoscere l’imprenditore Daniele Kihlgren, un personaggio da me menzionato tante volte imprenditore sin dal lontano 2009 quando, a seguito del terribile terremoto di L’Aquila, raccontai dell’esempio virtuoso di Santo Stefano di Sessanio, da lui concepito e realizzato, un esempio virtuoso a livello strutturale – visto che i suoi interventi in tecnica e materiali tradizionali resistettero meravigliosamente senza nemmeno presentare cavillature negli intonaci, mentre la Torre Medicea, “restaurata e rinforzata” dalla locale Soprintendenza usando tecniche e materiali moderni, crollò miseramente – ma anche a livello economico e sociale …
Santo Stefano di Sessanio, come ha raccontato Kihlgren, è anche il luogo dove, grazie al successo di quanto fatto, il Comune ha deciso di demolire l’unico edificio moderno, posto ai margini del borgo, il cui aspetto avulso dal contesto disturba l’armonia del luogo.
Dopo il Forum Daniele è stato così cortese da inviarmi un testo che racconta questa fantastica esperienza, testo che mi ha autorizzato a divulgare tramite il mio blog, e che ho il piacere di riportare qui di seguito.
Sextantio – Santo Stefano di Sessanio
di Daniele Kihlgren
Dopo tanti anni di discussioni sulle aree interne e sul loro destino, sul tragico e irreversibile abbandono dei borghi di queste aree, e infine, dopo decenni da questo abbandono anche alla loro scomparsa fisica integrale quale patrimonio storico, un Comune in Abruzzo collocato in queste aree di marginalità, il comune di S. Stefano di Sessanio, ha deciso di procedere, dopo un tavolo tecnico informale con la Regione Abruzzo, a un piccolo ma estremamente simbolico gesto, premessa di nuovi destini e nuove destinazioni per questi territori e per un possibile modello replicabile: l’abbattimento dell’unico edificio moderno, particolarmente invasivo e di nessuna funzione sociale, abbandonato da decenni, collocato accanto la forma anulare di questo borgo incastellato tardo medievale, andandone a nascondere una parte rilevante del borgo se osservato dall’esterno e del paesaggio se osservato dall’interno.

Santo Stefano di Sessanio: l’edificio con balcone in primo piano è quello che verrà demolito (Foto di Daniele Kihlgren)

Santo Stefano di Sessanio: l’edificio che verrà demolito (Foto di Daniele Kihlgren)
Questa demolizione viene attuata per pure ragioni di tutela del rapporto costruito storico paesaggio.
L’obiettivo di tutela di questo patrimonio storico minore/vernacolare e del suo intimo rapporto con il territorio è particolarmente importante in quanto questo genere di impianto urbano, diversamente da quello della classicità, ha un rapporto fondante col paesaggio, innanzitutto “subisce” il territorio, costituendosi storicamente sulle originali curve di livello.

Scorcio notturno di Santo Stefano di Sessanio (Foto di Daniele Kihlgren)

Scorcio di Santo Stefano di Sessanio (Foto di Daniele Kihlgren)
Il materiale di costruzione è quello locale e da qui derivano armonie cromatiche di chiara suggestione, che fondono ulteriormente il costruito storico col paesaggio. Infine, fattore semplice ma determinante, data la modesta dimensione di questi borghi sulla montagna appenninica, per ragioni meramente prospettiche, ogni edificio moderno diventa molto visibile, facendosi chiaramente detrattore rispetto all’originario rapporto tra costruito storico e paesaggio.
Dunque il borgo storico vernacolare o “minore” con il suo paesaggio, sebbene lontano dai paradigmi della “classicità”, dovrebbe essere ugualmente considerato “patrimonio”, e quindi da conservare e tutelare a livello istituzionale in questa suggestiva e integra reciprocità costruito storico/paesaggio.
Il non costruire in questi specifici luoghi diviene fondamento del potenziale sviluppo economico, oltre alle sue valenze culturali ed estetiche. E di questo può essere esempio proprio la vicenda di S. Stefano di Sessanio.
Già dalla fine degli anni ’90, un’iniziativa privata ha iniziato un’operazione di restauro di parte del borgo, oggetto di un’operazione di recupero effettuata portando alle estreme conseguenze gli aspetti identitari con la scelta di conservare le tracce del vissuto storico esterne ed interne del tessuto Architettonico, tramite materiale iconografico (fotografie provenienti dal Museo delle genti d’Abruzzo), la conservazione degli arredamenti storici (da intendersi, fino a quando erano autoprodotti in loco) e tramite interviste agli anziani (sempre con il Museo delle genti d’Abruzzo), la riscoperta e riproposizione di alcuni aspetti delle culture materiali quali il cibo e l’artigianato domestico.
Universi antropologici sul limite della loro definitiva scomparsa.
Queste azioni e la loro spontanea promozione hanno portato a un indotto sul territorio evidente nel moltiplicarsi delle strutture ricettive simil alberghiere, passate da una a ventitré nel volgere di questi anni, e il numero delle partite IVA che, comprendenti anche ristoranti, locali e botteghe, stanno raggiungendo il numero degli abitanti (circa 55 su 70 residenti reali).
Un’ultima considerazione. Grazie a queste nuove economie, un borgo che già aveva negli anni ’90 previsto il decennio, all’incirca, del suo totale abbandono, ha visto i giovani iniziare attività in loco e produrre una discendenza, invertendo la tendenza dopo generazioni di drammatico calo demografico.
Un progetto di economia sociale sui borghi delle aree interne che potrebbe essere considerato il più interessante, per il suo valore insieme culturale ed economico, per promuovere queste aree, che dovrebbero diventare la meta di un turismo sensibile e sofisticato che da secoli è interessato non solo ai patrimoni della classicità passata, bensì anche a patrimoni storici meno importanti ma dal forte carattere identitario.
Oggi, con lo sviluppo esasperato e irreversibile del mercato globale e del prodotto turistico globalizzato e tutte le conseguenze in termini di identità, questi luoghi della marginalità possono rappresentare un’Italia ancora autentica nel paesaggio, nel costruito storico, nel suo cibo e nel suo artigianato.
Questo progetto risulta più applicabile nelle aree interne del nostro meridione, in quanto nel Sud c’è stato maggiore abbandono e forse anche una storia, nell’età di mezzo, più importante, che ha visto la nascita di molti di questi borghi incastellati.
Secondo l’esperienza e i numeri di due decenni di varie attività, le attività economiche ideali sono le gestioni prettamente familiari.
Tutto quanto premesso sullo sviluppo economico di un progetto culturale di tutela e sulle gestioni familiari quali attività ideali per l’investimento nella ricettività e attività correlate, agli enti territoriali è riservata l’enorme responsabilità di garantire la tutela in tutte le sue declinazioni, per fare avvenire questa rivoluzione copernicana, un nuovo e nobile futuro per queste aree che sembravano irrimediabilmente destinate all’abbandono.
Per quanto riguarda tali aree interne questo modello di sviluppo dovrebbe essere il più competitivo.
In tutto il paese sono stati calcolati da 2000 a 6000 borghi completamente abbandonati che tra un secolo saranno un ammasso di ruderi, quelli semi-abbandonati sono di un numero logaritmicamente maggiore, ma solitamente hanno qualche detrattore architettonico e qualche edificio della modernità.
Tutta questa architettura vernacolare o povera o minore è abbastanza assimilabile almeno all’interno di una singola regione geografica, e il vero e solo valore aggiunto culturale, estetico e quindi economico di questi borghi è la mancanza dei detrattori architettonici della modernità che ne abbiano violato l’integrità dal dopoguerra ad oggi.
Se questo modello dovesse prendere piede, vista l’enorme quantità di siti potenziali, una maggiore offerta dovrebbe limitare il fenomeno della sovraesposizione turistica (overtourism) che, per quanto reversibile, arriva anche in queste lande marginali, almeno in alta stagione, con la conseguente decadenza dell’accoglienza turistica e di tutti i suoi prodotti, dal cibo all’artigianato.
Se poi si affronteranno con il massimo impegno possibile le varie declinazioni del complesso concetto di identità, si autoselezionerà il turismo più interessante.
La replicabilità di questo progetto è verosimile.
Siamo cresciuti in un paradigma culturale in cui la cultura è stata spesso un costo, possibilmente per nobili progetti ma sempre a un costo. In questo caso la cultura, nello specifico la tutela di questo patrimonio vernacolare, di questo patrimonio senza architetti, di questo patrimonio povero o minore in concerto col suo paesaggio, ha già portato a conseguenze manifestamente economiche per il territorio locale. Un progetto culturale e di economia sociale da riproporre in tanti luoghi storici abbandonati o quasi che, per quantità e tipologia, solamente l’Italia può offrire.
Forse siamo un paese che ha perso competitività in molti settori ma sul nostro patrimonio storico e su questo specifico patrimonio storico non sempre considerato come “patrimonio” tale, nessun altro paese ci può fare concorrenza.
Un’ultima considerazione: mentre le consuete strutture turistiche tradizionali sono spesso “capital intensive”, con costi elevati di avvio e gestione, e molte destinazioni turistiche famose convivono con uno scarso ritorno per la popolazione locale, i borghi rappresentano un modello completamente diverso. Qui, la struttura media si compone di poche stanze (generalmente tra 4 e 8) ed è spesso già di proprietà familiare o di un parente emigrato, riducendo significativamente i costi iniziali.
Gli investimenti necessari per restaurare e adattare questo genere di proprietà alla ricettività turistica sono solitamente accessibili alla maggior parte delle famiglie italiane. Inoltre, esistono opportunità di finanziamento pubblico, attraverso programmi regionali, nazionali o europei, che in alcuni casi possono coprire fino al 50% dei costi dell’investimento.
Questo modello non solo democratizza l’accesso all’imprenditoria turistica, ma favorisce anche lo sviluppo di economie locali più equilibrate. Le strutture a gestione familiare tendono a reinvestire nel territorio, promuovendo un turismo più sostenibile e attento alla comunità, evitando così il fenomeno del “tourism leakage” (drenaggio economico), tipico delle grandi catene alberghiere.
Di conseguenza, i borghi possono diventare un volano di sviluppo economico per le aree interne, garantendo al contempo la tutela del patrimonio e il miglioramento della qualità della vita per la popolazione residente.
[1] https://piervalleit.blogspot.com/2021/05/lantico-borgo-di-veglio-in-comune-di.html